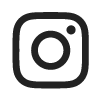Nella sua biografia, “ Lady sings the blues” del 1956 Billie Holiday scrisse:
“La mamma e il babbo erano ancora ragazzi quando si sposarono, Lui diciotto anni, lei sedici, io tre.”
Nata a Baltimora nel Maryland il 7 aprile 1915 Billie è stata una tra le interpreti più grandi della storia del jazz.
Nella sua vita niente è stato facile: né l’infanzia, né l’adolescenza, né in generale tutta la sua vita. Il suo vero nome era Eleonora Fagan Gough (o Eleonora Harris) ma scelse il nome d’arte Billie Holiday come omaggio all’attrice Billie Dove di cui era una grande ammiratrice.
Visse poveramente seguendo in giro per New York sua madre, che puliva scale e locali pubblici e, si guadagnò il soprannome di “lady” dopo essersi rifiutata di ripetere un gesto in cui ballerine e cantanti sollevando la gonna prendevano banconote lasciate sui tavoli dai clienti nei locali in cui si esibivano.
Lo trovava degradante.
Questo soprannome fu una parte dello pseudonimo usato da Billie per esibirsi fino a quando il suo grande amico Lester Young non vi aggiunse un “day” trasformandola in “Lady day”.
Un bianco mazzolino di gardenia offertole da una’ammiratrice, divenne uno dei suoi segni distintivi.

Vocalmente non possedeva certo i fuochi d’artificio tecnici di Ella Fitzgerald, il suo “scatting” limpido né la versatilità e la profondità timbrica di Sara Vaughan; ma l’incedere spezzato dei suoi fraseggi, la vena malinconica delle sue interpretazioni ne fanno un’interprete raffinata e moderna.
Molte erano le caratteristiche distintive della sua voce: il rifiuto dello scat (lo scat è una tecnica di canto; di improvvisazione vocale, in cui il cantante non utilizza più il testo ma dei semplici fonemi e delle invenzioni ritmiche o anche melodiche; la voce viene usata come puro strumento musicale. Ricordate il”di bup pa du bi du” di Armstrong? Non vi ricorda una tromba?), l’analisi al microscopio di ogni parola a cui veniva restituito il significato più esatto in ogni sillaba; la concezione rilassata del beat (simile a quella del suo grande amico Lester Young) che la portava a fraseggiare in maniera imprevedibile come in una sorta di “parlare – cantando”in modo particolare negli ultimi anni della sua vita, quando la sua voce (sfibrata da uno stile di vita non sano e cattive abitudini) aveva preso un colore particolarmente scuro.

Una voce straordinaria in un mondo incapace ormai di ascoltare l’Anima di una voce. Billie, sia che canti un testo come quello di “l’Il Get By” sia che ne affronti uno più semplice come quello di “What A Little Moonlight Can Do” esige dall’ascoltatore il massimo impegno.
Lei non è una cantante lei è LA CANTANTE. Lei ti scava dentro.
Puoi ascoltare Billie Holiday, certo! Percepirne tutta la grandezza ed anche amarla, ma per capirla è necessario che prima la vita ti abbia logorato e maltrattato un po’, devi avere avuto il tuo buio e solo e soltanto allora comprenderai le canzoni della Holiday, perché sono davvero tanti i brani splendidi cantati da Billie.
Lover man, una ballata malinconica. Il testo sembrava scritto per lei: “sono così triste, ho un gran desiderio di provare quello che non ho mai provato, non ho mai avuto baci, e che cosa mi sono persa” .
God bless the child, che parla dell’ipocrisia di un mondo in cui i musicisti neri vengono trattati come grandi artisti, ma devono entrare sempre dalla porta di servizio come i domestici.
I’m fool to want you, tratta da Lady in satin del 1958 (la sua voce segnata da eccessi di droga ed alcool e da tanta sofferenza è stanchissima ; ma in questo disco lei non canta, bensì incanta e vive); sembra il brano di addio della grande Billie. Una scansione delle parole fantastica.
You don’t know what love is: da brividi!
The man I love, del 1939. Il brano per antonomasia della grande Lady Day. Il pezzo cantato dai più grandi, trova nelle corde di Billie la sua giusta dimensione così come “Body and Soul”.
Strange fruit, considerata anche dal “TIME” il monumento musicale del secolo scorso. Una canzone coraggiosa, bella ma anche molto dura e agghiacciante sul linciaggio dei neri negli Stati Uniti del Sud. Un brano di denuncia sociale in un’epoca in cui le battaglie per i diritti civili non erano neppure all’orizzonte, e che lei non riusciva a cantare senza commuoversi.
I’ll be seeing you, commovente

Cover dell’album “Song for distingué lovers”
Che dire infine dell’album Songs for Distinguè Lovers (1957), che spicca su tutte le altre incisioni grazie alla presenza e al talento di grandi musicisti come Webster al sax, Mitchell al basso e Rowles al piano; album in cui raggiunge la sua sconvolgente maturità espressiva. Fantastica la sua voce che avvolta da un velo di malinconia pone il suggello definitivo a classici come Stars fell on Alabama e I didn’t know what time it was.
Nel 1950 dopo la sua ultima incisione, subisce un attacco di epatite e viene ricoverata in ospedale a New York. Muore il 17 luglio, all’età di 44 anni.
Grande, grandissima Billie; una stella che non smetterà mai di brillare.
“… Lady Day cantava con l’anima dei neri e nelle sue canzoni risuonavano secoli di dolore e oppressione…”(Malcolm X)
(articolo curato da Maxi Maximilian)